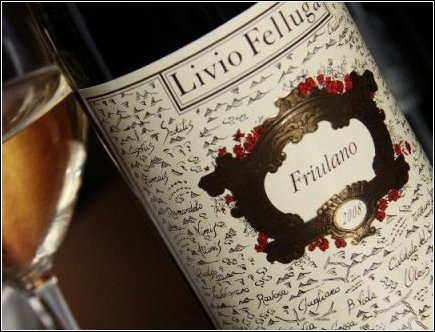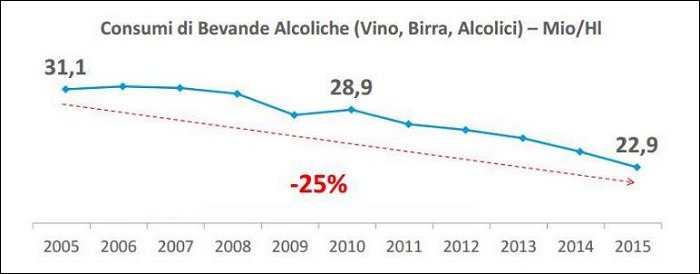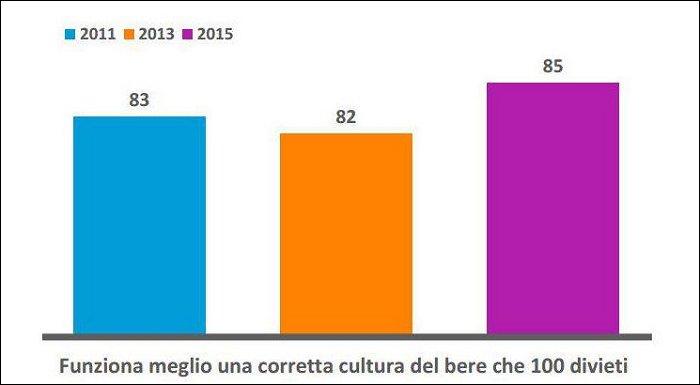![Il Post e l’agricoltura biodinamica. Cronaca di una storia che non abbiamo scritto, salvo ripensamenti Il Post e l’agricoltura biodinamica. Cronaca di una storia che non abbiamo scritto, salvo ripensamenti]()
La settimana scorsa Il Post ha chiuso, a modo suo, il dibattito sui vini biodinamici. Nel pezzo titolato “L’agricoltura biodinamica è una cosa seria?” (e già il titolo da solo era una discreta calamita), il passaggio che ci rileva è, esattamente, questo qui:
«Molti produttori di vino biodinamico sostengono che il sapore dei loro prodotti è cambiato da quando hanno iniziato ad utilizzare i metodi di Steiner, ma per definizione ogni annata di vino – biodinamico o meno – è differente dall’altra. Che sia più o meno buona è, in genere, una questione di gusti personali».
E basta. Fine del dibattito. Beh, è stato facile, no? In fondo questa liquidazione un po’ sommaria del mega dibattitone nel quale ci arrotoliamo da anni ha svariati punti di fascinazione: per esempio ci svela (per la millesima volta) che fuori dal nostro fazzoletto di orto quasi nessuno ama dilungarsi in distinguo estenuanti sul vino biodinamico.
Poi succede un altro fatto. Nel gruppuscolo intravinico discutiamo un po’, appunto, della sommarietà di quella frase, che però tanto mi affascina, essendo io così attratto dall’abisso di chi la pensa in modo diverso. Va be’, al netto di questi personalismi (ma che diamine, questo è un blog, io personalizzo) arriva Jacopo Cossater ad illuminare quelli dentro al quartierino intravinico, che partecipavano alla riunione di redazione/cazzeggio, con un’osservazione che ci mette tutti d’accordo. Scrive infatti Jacopo:
«L’argomento mi sta abbastanza a cuore ma trovo che il suo dibattito fatichi a trovare una qualunque via d’uscita, e il problema ha a che fare da una parte con i suoi detrattori più feroci e dall’altra con i suoi sostenitori più ciechi (magari produttori di vini di dubbia qualità). La questione che sfugge ai primi, credo, è la fortissima componente spirituale che la biodinamica porta con sé, una sorta di “voglio credere” che – in estrema sintesi – ha più a che fare con un percorso di ricerca interiore che con l’agricoltura in sé. Poi possiamo girarci intorno quanto vogliamo ma biodinamica è quantomeno sinonimo di biologico (se non di più, di biologicissimo), basta fare una passeggiata in qualunque vigneto steineriano per avere la sensazione di trovarsi in un luogo “sano”, qualunque cosa questo termine voglia dire. Tutto questo naturalmente non è necessariamente sinonimo di vino buono, è però altrettanto vero che in genere – generalizzando molto – chi dimostra questo tipo di sensibilità in campagna ne riporta buona parte in cantina traducendo il tutto in un certo non-interventismo spesso virtuoso, capace di portare a vini certamente non banali. Che ci siano produttori biodinamici di eccezionale valore non credo sia cosa da sottolineare, vero però è anche l’opposto, con il risultato di trovarsi di fronte a vini davvero dimenticabili che spesso nascondono più o meno accentuate spigolature dietro alla bandiera del “naturale” a tutti i costi (atteggiamento che personalmente sopporto a fatica)».
Avendo tutti quanti letto il pensiero su riportato, ci guardiamo tra di noi e ci facciamo i complimenti: caspita Jac è bellissimo, qui hai praticamente un post già scritto, pubblichiamolo. E cose così. Tuttavia ci chiediamo anche, tutti, se ha senso. Ha senso davvero riparlarne? Quello che ci blocca, ci stucca e ci annoia, è esattamente l’idea di andare a risvegliare “da una parte i detrattori più feroci e dall’altra i sostenitori più ciechi”.
E mentre siamo lì che ci rimiriamo l’ombelico, proprio il giorno dopo Michele Serra dedica la sua amaca a quell’articolo:
![Serra]()
Letto il quale balza agli occhi che, hey, Serra ha detto all’incirca quel che diceva Jacopo. Nuovamente ci rallegriamo tra noi e ci facciamo i complimenti, anche perché è bello vedere che qualcuno, là fuori, s’è incaricato di fare il lavoro sporco.
Difatti mezz’ora dopo comincio a leggere sui social i primi feroci distinguo su quanto affermato da Serra, il più lieve dei quali potrebbe essere “Serra è il solito radical chic”.
Quindi, manco a dirlo, Il Post ci ritorna su, in modalità rispondiamo a Serra. Tale risposta si articola (tra l’altro) in questo passaggio:
«Serra mette biologico e biodinamico sullo stesso piano e dice: visto che entrambe le tecniche procurano dei vantaggi in termini di minore impatto ambientale, allora meritano il nostro plauso. Serra ha in parte ragione, perché effettivamente l’agricoltura biodinamica poggia su due pilastri, quello biologico e quello “spirituale”, costruito intorno alle teorie di un filosofo e mistico tedesco morto nel 1925. La parte “biologica” è quella che piace a Serra, ma non possiamo fare finta che la parte esoterica non esista».
Questo passaggio è importante, in quanto segna il distinguo maggiore, più profondo e meno sanabile tra i contendenti: il metodo scientifico da una parte, l’esoterismo dall’altra. Non so voi, ma io non vedo grosse vie di uscita in questo dibattito (e nuovamente devo appellarmi a quanto scritto da Jacopo).
Però la mia impressione è che stavolta coglie il punto Pietre Colorate, quando nella sua pagina Facebook rilancia così il pezzo numero due: il dibattito “sembra riaprirsi, ma a tutto vantaggio, temiamo, della confusione e della superficialità”. Peraltro vi segnalo il commento maggiormente votato al secondo post de Il Post (quanto odio sto bisticcio, ma non potevate chiamarvi a un altro modo?) che dice, sempre tra l’altro:
«Quello che non capisce Michele Serra, così come la maggior parte delle persone, è che un’agricoltura intensiva permette di preservare gli ambienti naturali: se per esempio un paese come la Cina si convertisse all’improvviso ai dettami dell’agricoltura biologica, con le sue rese ridicole ed il suo sfruttamento altamente inefficiente delle risorse, per sfamare il miliardo e passa di cinesi si andrebbe incontro ad una vera e propria apocalisse ecologica di proporzioni inimmaginabili. Per nostra fortuna i cinesi la pensano diversamente da Michele Serra».
Arrivati a questo punto, siamo certi solo dell’incertezza. Per quanto mi riguarda, parlando di vino la mia opinione l’ho espressa molte volte, sempre in termini favorevoli ai bioqualchecosa. Voglio però dirvi anche un altro fatto: è capitato anche a me, qualche volta, di avere bisogno di un medico. In quei casi mi sono affidato con grande serenità a big pharma, mi sono fatto iniettare cose kimike, è andato tutto molto bene ed eccomi qui: ancora vivo.
Ve l’avevo già detto che è un mondo difficile? Ecco.
[Immagine principale: La Raia]





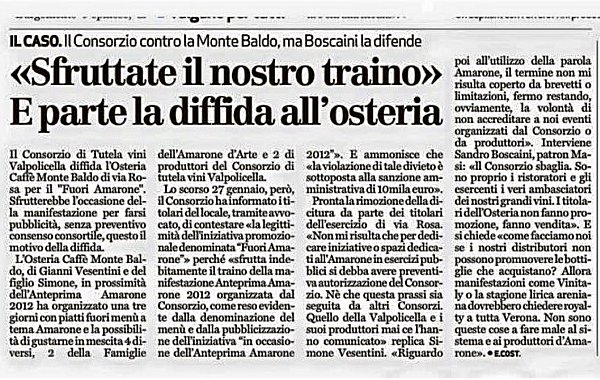






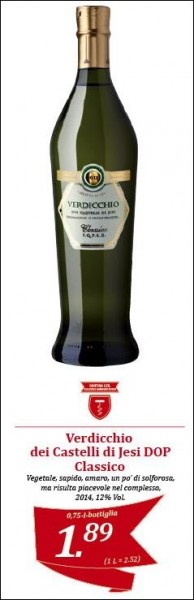
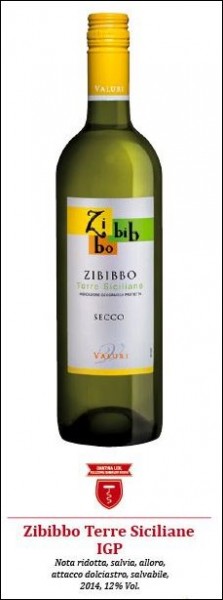














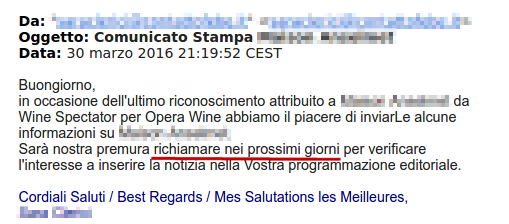


 Ecco, quell’etichetta del vino sul tavolo… aspetta un attimo:
Ecco, quell’etichetta del vino sul tavolo… aspetta un attimo: Mi ricorda un altro vino. Che, ahem, sarebbe notoriamente di un’altra regione. Friuli Venezia Giulia, per l’esattezza:
Mi ricorda un altro vino. Che, ahem, sarebbe notoriamente di un’altra regione. Friuli Venezia Giulia, per l’esattezza: